Vasco Bendini, Bram Bogart, Rafael Canogar, Karl Otto GOEtz, Sebastián Matta, Pietro Ruggeri ed Emilio Scanavino
30 marzo 1962
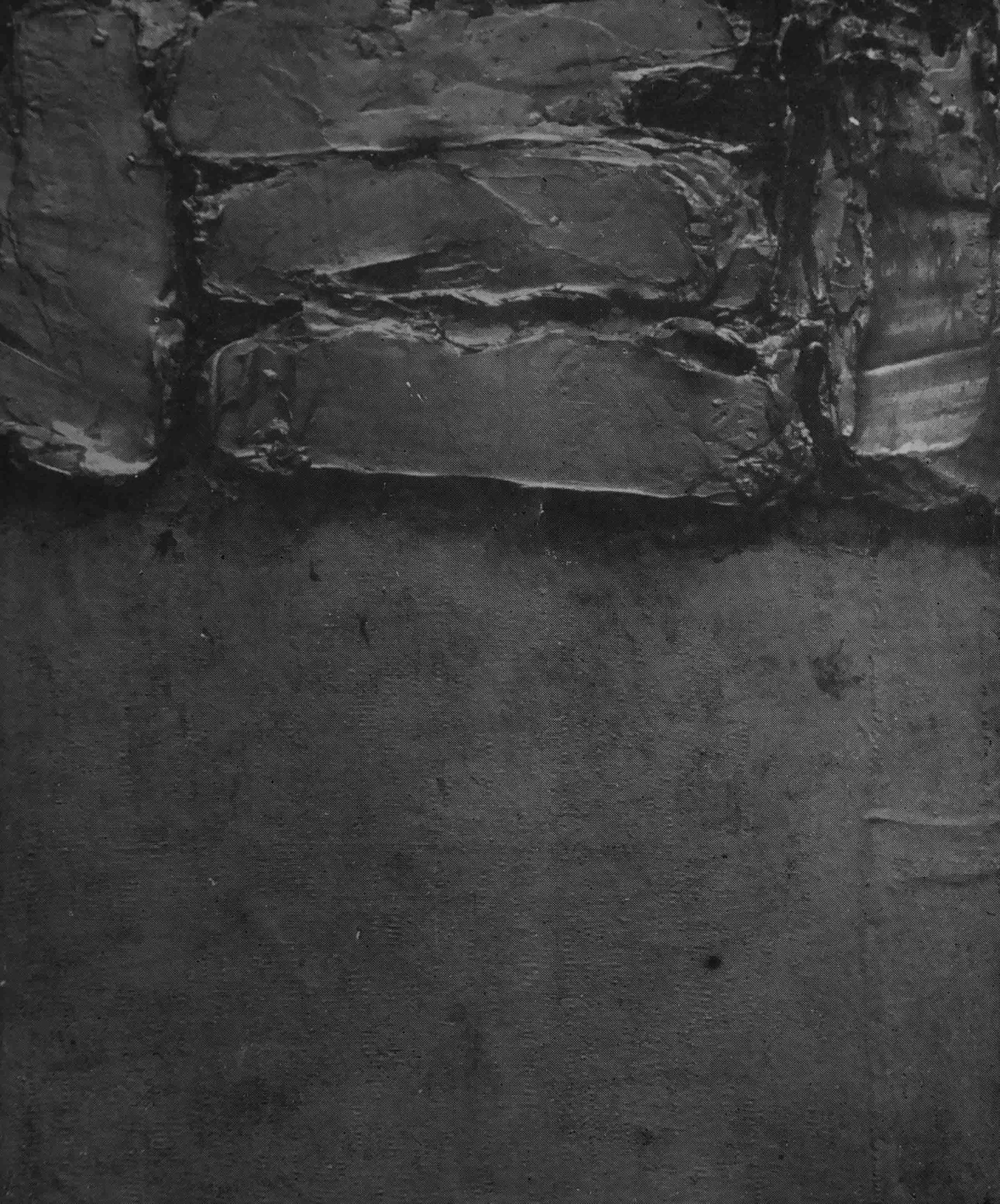
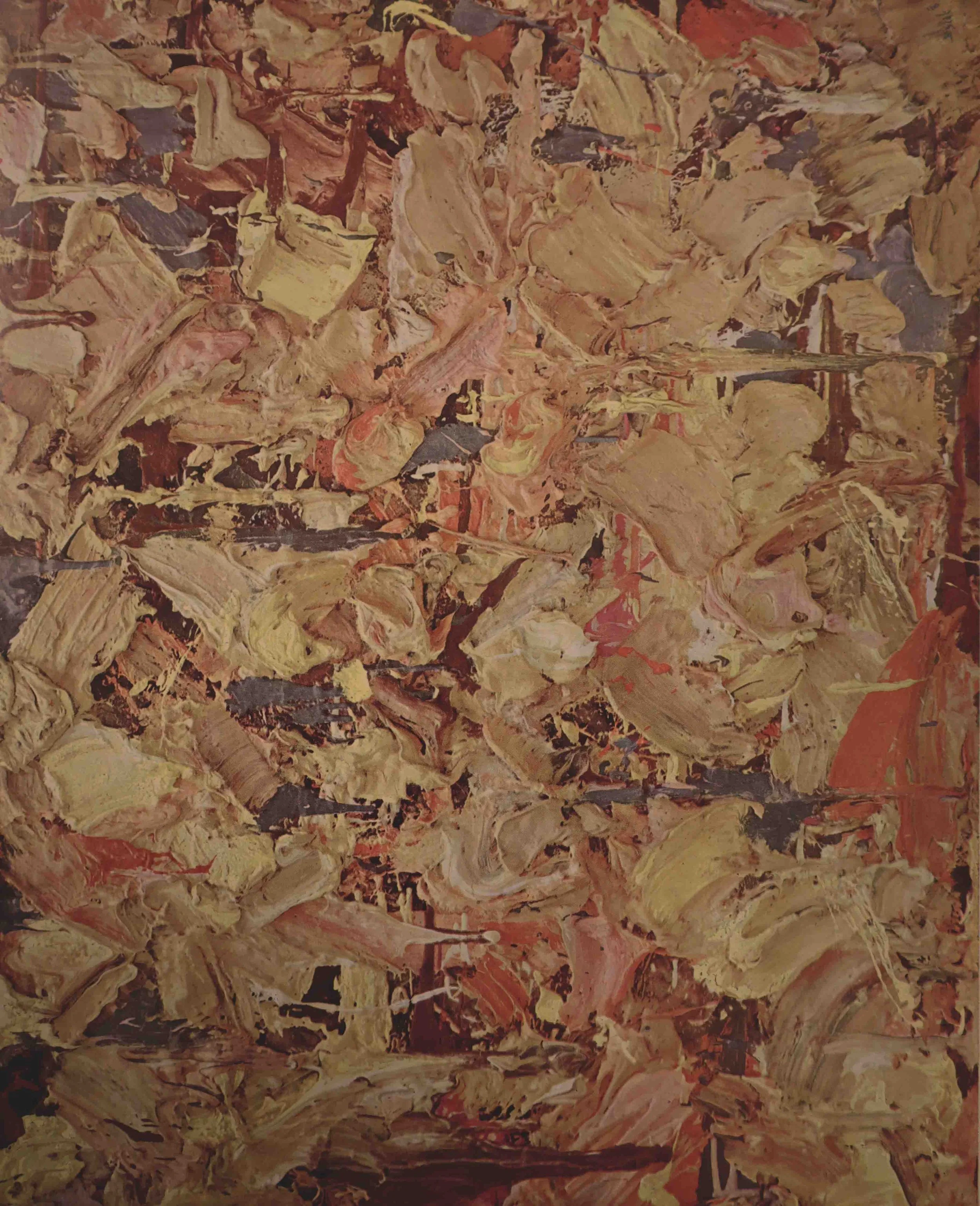
La mostra inaugurata il 30 marzo 1962 presso la Galleria de’ Foscherari di Bologna, in collaborazione con la Galleria “L’Attico” di Roma, si colloca in un momento cruciale per la riflessione estetica e per il dibattito critico italiano. Il testo di Maurizio Calvesi, che accompagna l’esposizione, non si limita a presentare gli artisti in mostra — Vasco Bendini, Bram Bogart, Rafael Canogar, Karl Otto Goetz, Sebastián Matta, Pietro Ruggeri ed Emilio Scanavino — ma si propone come un’ampia meditazione sulla condizione dell’arte dopo l’esperienza informale, della quale egli riconosce insieme la ricchezza e i limiti.
L’intervento di Calvesi assume i tratti di una diagnosi culturale: l’informale, inteso come gesto estremo di immersione nell’esistenza, ha portato con sé la consapevolezza di un “arresto” della storia, di una frattura che costringe a ripensare il rapporto fra natura, cosmo, inconscio e futuro. Da tale frattura non nasce però un esito negativo o puramente nichilistico, ma l’esigenza di un salto qualitativo, di un’apertura verso nuove dimensioni della pittura, capaci di coniugare la lezione informale con una rinnovata tensione verso l’immagine e verso lo spazio.
In questa prospettiva la mostra non si configura come semplice rassegna di tendenze, bensì come laboratorio di ipotesi: le opere di Bendini, Ruggeri e Scanavino, radicate nella continuità e nel superamento dell’informale, si pongono accanto a quelle di artisti come Matta e Goetz, che già sperimentano un linguaggio proiettato verso dimensioni cosmiche e visionarie, mentre Bogart e Canogar si confrontano con una nuova idea di natura, materica e insieme trascesa. Ciò che emerge, al di là delle singole poetiche, è la ricerca di una “nuova natura dell’uomo”, di una dimensione spirituale e psichica che tenta di integrarsi con la percezione del cosmo e con le metamorfosi della modernità.
La rassegna bolognese diviene così, nelle parole di Calvesi, non solo occasione espositiva, ma testimonianza di un momento di passaggio: l’arte, dopo la crisi dell’informale, si pone come luogo privilegiato per interrogare il destino dell’uomo storico e per aprire, attraverso le proprie forme, la possibilità di una nuova prospettiva.


“Ora che l’esperienza informale, un’esperienza straordinariamente ricca e confusa, di cui si faranno sempre più chiari col tempo tanto i limiti che le possibilità (che sono, forse, i limiti con le possibilità dell’uomo “storico”, misurati sul fallimento dell’ipotesi metafisica); ora che l’esperienza informale s’è in qualche modo conclusa e depositata nelle stesse coscienze che ne hanno partecipato, sta prendendo forma oggettiva di pensiero una denuncia conclusiva: si denuncia un arresto, un arresto che sa di fine della storia. Un punto a capo nelle vicende dell’umanità (che sia l’arte a segnare questo a capo, non sorprende; perché l’arte congloba l’intera esperienza dell’uomo, è istinto e pensiero; è istinto che si fa pensiero, o meglio, pensiero che si fa istinto).
Ma oltre questo arresto è ripossibile proporre, all’uomo, l’uomo, alla storia, la storia? Se crediamo ancora nell’ipotesi autre, ma vogliamo sortire dal vicolo cieco dell’alienazione, non ci rimane che pensare a questo “altro” in termini di una nuova dimensione umana, una dimensione ignota, è vero, ma che funzioni comunque da prospettiva. Una dimensione che sia abitabile per l’uomo, oltre la stessa visione adimensionale, impraticabile dell’art auter.
Non si tratta più evidentemente, di credere o non credere in Dio; ma di credere o no nel futuro. L’ipotesi metafisica, per sopravvivere a mutarsi radicalmente, è costretta a spostarsi da un a priori verso un a posteriori. L’uomo uscente della storia guarda al futuro in termini di catarsi, e ancora trascendenti, rispetto almeno alla storia stessa.
Per subendone le trasformazioni, cioè concedendo un volto sempre nuovo alle sue variabili prospettive, la natura precede la storia; e la storia torna ad oggettivarsi in natura. Dobbiamo quindi porci il problema primo. Un’ipotesi vertente sul futuro non potrà che riguardare la natura, cioè l’ambiente esterno-interno dell’uomo, le cui estreme propaggini del cosmo e dell’inconscio aspirano, in questa ipotesi, a svelarsi in una comune verità.
Da questa ipotesi non potremo scartare, a priori, alcun elemento: né la scienza né l’immaginazione; ancor meno i sintomi dell’arte, la cui capacità di raggio può essere massima. Ma dovremo scartare o almeno accantonare (ai fini di un’ipotesi siffatta) ogni proposta che appaia ancorata ad un concetto sostanzialmente immobile così di natura come, per conseguenza, di storia. Dovremo ripudiare tanto i naturalismi quanto gli anti-naturalismi basati su una percezione tradizionale di natura; i razionalismi che tornano a proporci la storia come progresso immanente alla storia stessa; e con particolare tutti gli realismi che abbracciano concetti ormai spenti così di storia come di natura.
Per un ascolto indisturbato delle voci che ci piacerà evocare, dovremo altresì allontanare le interpretazioni falsanti e tendenziose; sventare le appropriazioni indebite, vecchie e recenti, di Boccioni ad esempio, o del surrealismo, o di Pollock; o dallo stesso Caravaggio.
Il filo del discorso infatti, per grandi salti, in una prospettiva bruscamente abbreviata, si può ripreendere di lì; anzi da Michelangelo, cioè da quel messaggio estremo e fallimentare del Rinascimento che è il “Giudizio”. Michelangelo ha, qualche anno prima di Copernico, una tetra intuizione sulle leggi di uno spazio sottratto alla gravitazione, fisica della terra e spirituale dell’uomo. Questo spazio assume una dimensione psichica, da incubo. È un’intuizione inconscia del cosmo e cosmica dell’inconscio. Ma il cosmo e l’inconscio gestano una immane minaccia, che si personifica in Dio.
Con Caravaggio l’idea di Dio, come suggestione panica e come dubbio esteso, si riassorbe nella dimensione stessa del cosmo. Una dimensione infinita ed oscura, che resta sottintesa, suggerita per contrasto con il chiaro e con il finito; un infinito abitato dall’ombra irresoluto o sospeso nel dubbio di Dio.
Quando opera Pollock, l’idea di Dio è già spenta, e sotto il cappuccio della prima esplosione atomica sono sepolti anche gli idoli illuministici che l’avevano surrogata. I limiti della società e della storia sono divenuti intollerabili per l’uomo; ma in mancanza di ulteriori risorse metafisiche e di ulteriori mezzi di esplorazione, solo l’allucinazione può forzare questi limiti. C’è un’ipotesi cosmica, allucinata, di Pollock. Non potendosi fondare su un’idea di Dio, né di storia, Pollock si fonda su un’idea di natura, un’idea internamente antica. L’ifininito delle praterie è una falsante immagine d’infinito; è solo un simulacro d’infinito; è un’illusinone istantanea di varcare il limite; ma questa illusione non può prolungarsi e farsi durevole che nell’allucinazione, nella vertigine; perciò la dimensione di Pollock è pura vertigine; vertigine dell’inesplorato, vertigine di ricaduta.
È troppo semplice pensare che Gagarin sia l’antidoto di Pollock; né possiamo credere, all’improvviso, in una soluzione semplice; non vogliamo né assumerlo né escluderlo. Né vorremmo ricadere in un’ipotesi futurista. Ma i futuristi, se ascoltati con quel credito e quella disponibilità cui hanno diritto, sono i primi a insegnarci che questa ipotesi è stata, talvolta, meno semplicistica, più coinvolgente, più dura, più piena di quanto si sia soliti credere.
Il bersaglio di Boccioni è ancora la natura tradizionalmente percepita, sia pure nella nuova sintesi visuale dei cubisti; ma su questo bersaglio egli apre il fuoco. L’agglomerato del visibile entra in moto come una macchina gigantesca, che fa violenza ai suoi stessi meccanismi; dai suoi ingranaggi naturali spurga bave metalliche, luci come lame, maschere d’incubo. “Materia” è un immagine cupamente incandescente, di caos. Dall’uovo di Klee non possono che nascere forme; dal caos di Boccioni nasce materia, materia per una nuova natura, una natura che, nell’ipotesi avventurosa di se stessa, si contrappone all’antica come artificalità.
È, d’accordo, un caos libidinoso di sensazione fisiche, di sverginamenti, di verocità e d’aggressione. Ma questa libidine, come un’ esca calata nell’abisso, rimuove le aderenze magmatiche dell’inconscio e le attira alla superficie. L’innaturalità, l’artificiale, l’inconscio aspira a farsi natura, in un aspro conato genetico. Il caos dissonante di Bocconi si evolve nella cosmogonia di Max Ernst. Ma nell’ipotesi surrealista l’inconscio soverchia la volontà dell’uomo. Egli diviene vittima dell’automatismo, cioè di uno scatto cieco che riproduce, all’interno dell’uomo, le condizioni di inesorabilità del suo nuovo ambiente meccanico. L’artificiale e l’inconscio si incontrano in una pura ipotesi di anti-natura.
Matta avvia un’ipotesi di polo contrario, metamorfica; l’artificiale e l’inconscio si sposano in un’attiva dimensione cosmica, in cui l’uomo individua una sua possibilità, quasi alchimistica, di trasformazione. Spazi fosforescenti, ad alta tensione; spazi acidi e refrattari ma pure attinti dal segno intrigante dell’uomo: uomini-cuspide, come dice Villa, uomini-aspidi, uomini-coltello. Il segno automatico dei surrealisti, il segno testimoniale degli informali si ricaricano di possibilità attivistiche. È un segno che entra in orbita; segno abitacolo per nuove esplorazioni.
In Pollock l’aspirazione è il divenire, l’illimite, ma la fatalità è l’essere, il limite; l’essere come limite. Matta opta per un’ipotesi d’essere come puro divenire; un divenire non storico né naturale, ma che salta la storia e la natura, ipotecando il futuro.
Anche le traiettorie di Goetz entrano in orbita. Il segno di Kline, decisamente, occlude, sbarra; è la metafora istintiva e autre di un concetto di limite, polarmente equivalente al concetto d’infinito di Pollock. Goetz, sdrammatizzando, ad un livello poetico meno teso, sembra assecondare l’ipotesi di uno spazio che sia “altro” nelle sue strutture e non nelle sue metafore, di un concetto spaziale non opposto ma ulteriore rispetto al concetto di limite.
I nomi di Matta e di Goetz ci introducono concretamente all’occasione di questa mostra. Con essi, espongono altri pittori più giovani, in una scelta non tanto programmatica ed esclusivista, quanto, direi, d’apertura. D’augurio, anche, a questa nuova galleria bolognese, per un orientamento aperto su una gamma di possibilità “ulteriori” le cui radici, almeno in parte, mi sembrano ancora recuperabili in seno allo stesso linguaggio informale: oltre agli schemi interni e più spesso esterni, imposti cioè dall’esterno; intrinsecamente alla sua stessa spinta di divenire, un divenire inteso, per la prima volta dall’informale, non come processo storico-evolutivo ma come salto qualitativo.
Di questi più giovani pittori, in effetti, la critica s’è occupata (ed io tra gli altri) in anni recentissimi di campagna informale: Bogart e Canogar che hanno fatto, per l’Italia, la loro prima apparizione di galleria in una collettiva informelle (da me presentata); Bendini e Ruggeri che ebbi occasione di riunire con altri giovani artisti informali in un mio scritto dello stesso momento; Scanavino a cui, da quel medesimo scritto, davo una voce.
Il succo dei miei commenti, allora, era questo: che l’informale, oltre le ipotesi limitative e para-esistenziali del puro segno, del puro gesto, della pura materia, dell’angoscia e della nausea obbligatoria, di un’espressione, infine, disperatamente confinata nel puro atto e nel puro presente, lasciava inalterata, anzi potenziava in quanto ne proponeva un nuovo estrinsecarsi, la possibilità di un’immagine e di un rapporto di valori, di un discorso riccamente coinvolgente e articolato.
Sarebbe, ora, da riscontrare quali esiti specifici ha dato questa nuova ricerca d’immagine; cercheremo, in altra occasione, di valutarlo. Ma questa volta ci interessa soprattutto di considerare quale può essere stato il riflesso operante di questa ricerca sull’ipotesi qualitativa di una “nuova natura” dell’uomo.
Il contributo di questi più giovani pittori si delinea, mi sembra, sulla via di un’ulteriore conquista del profondo, ulteriore rispetto alla mitificazione dell’inconscio operata dal surrealismo in termini, prevalentemente e sostanzialmente, di rappresentazione mostruosa e aberrante; sulla via di una positiva integrazione dell’inconscio, del dato psichico in senso funzionale, organico, alla dimensione spirituale dell’uomo: una dimensione spirituale che tenta di adeguarsi, per analogia di strutture interne, alla percezione esterna di un’attiva dimensione spazio-temporale, cosmo-organica. Può essere questo un dato comune, oltre le singole declinazioni psicologiche, al tempestoso attivismo psichico di Ruggeri; alle grafie medianiche e telecomunicanti, ubiquitarie, di Scanavino; o alle immagini intermittenti e dissipate, accentrate-disgregate di Bendini, generate dal contatto tra un dato organico di natura e un dato organico d’interiorità psichica.
A Canogar, facemmo credito di «una classe ed una chiarezza perentoria forse paragonabile a quella di un Tapies»; ma lo distinguevamo nettamente dalla “metafisica di Tapies” per il possesso di una “realtà imminente, sbarrata”. Come l’astrazione di Tapies opera per forza d’evocazione all’interno della storia, l’astrazione di Canogar opera quasi rabbiosamente all’interno di una realtà naturale. Quella di Tapies è una natura fossile e velata dal mito, quella di Canogar è una natura che riemerge dai miti, una forza estratta dal vivo e trasfusa nell’uomo, perché torni ad esplodere dall’interno dell’uomo.
Anche l’astrazione dell’olandese Bogart fa violenza alla terra. Egli guarda al paesaggio terrestre con l’estremismo aberrante di una distanza stratosferica o di una vicinanza di centimetri, un estremismo fuori scala rispetto alla natura e alla storia, alla tensione colorata di Van Gogh e alla lucidità geometrica di Mondrian, che egli coinvolge in un’ipotesi di radicale e organica trasformazione.
Mentre archiviamo la storia, ci rifiutiamo al solo compito di archivisti, anche a rischio di contraddire alle insorgenze del nostro pessimismo. La ragione è comunque, ancora una volta, posta sotto processo; non più, tuttavia, dall’irrazionale, non più dalla passione, ma da un nuovo istinto in fieri. La ragione, non la logica, se la ragione è una mera ginnastica e la logica è una funzione che si ricambia. Non è più neanche un processo alla ragione ma, vorremmo, una metamorfosi della logica.
L’informale s’è avventato nell’azione con un profondo bisogno di contemplazione, senza trovare una dialettica tra i due estremi, ma piuttosto riconoscendovi una disperata antinomia, ricomponibile, a prima vista, solo in un esito reciproco di nullità e di inutilità; un esito non dichiarato dall’informale, che ha lasciato in sospeso le sue conclusioni, ma subito mentalmente sollecitato ed espresso dal neo-dada, che ha accettato, acutamente, questa sospensione stessa come conclusione. Né possiamo escludere che sia la conclusione esatta. Ma ci può essere anche una conclusione più aperta, non tanto una conclusione contrapposta (e neanche, anzi, una conclusione), quanto una proroga delle possibilità contrapponibili: possibilità di ricambio logico, suggerite non già dalla logica dell’informale, ma dalla sua stessa, intrinseca vitalità organica.
Il problema, comunque, è stato ampiamente messo a fuoco dall’informale, e ciò che può insidiare le possibilità ulteriori (se esistono) di un esito positivo non è la sospensione neo-dada, che è, a suo modo, ancora una provocazione all’inerzia, ma le tregue ipocrite, la reazione, la speculazione di parte, e di più parti, interessate soltanto alle proprie ipotesi di potere.
Cocteau ha scritto che ogni “evviva” comporta un “a basso” e che bisogna avere il coraggio di questo “a basso,” “sous peine d’éclectisme”. Ma quando si tratti, come oggi, di scegliere tra un’ipotesi di vita e un’ipotesi di morte, l’eclettismo può essere preferibile al semplicismo. Lo stesso informale ci ha proposto questo eclettismo, questa ambiguità di esiti divergenti. Una volta oggettivate le ipotesi, l’ambiguità diventa condizione di attesa. La discriminazione può invece farsi, ancora, tra autenticità e inautenticità, autenticità come vita (e autentica può essere anche un’ipotesi di morte, viva almeno in noi) e inautenticità come morte (inautenticità, o ipocrisia, e il nostro “a basso” è per questo). “
Maurizio Calvesi









